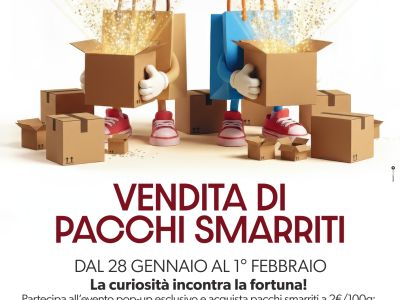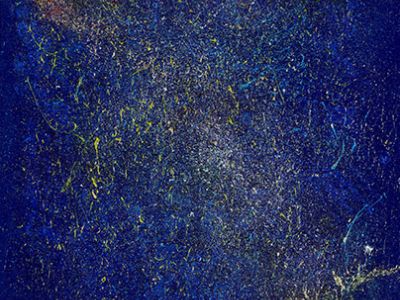Elettra e l’ombra della madre: mito e psicoanalisi del legame ferito.
«Chi dovrei chiamare madre? La donna che ha versato il sangue di mio padre?»
— Eschilo, Le Coefore, v. 111
Nel mito, come nella psicoanalisi, le figure non sono mai solo personaggi: sono strutture psichiche, tensioni profonde, fratture fondative.
Elettra, figlia di Agamennone e Clitemnestra, incarna uno di questi nodi irrisolti: la lacerazione originaria tra madre e figlia, l’impossibilità di un’identificazione serena, il rifiuto di un’eredità vissuta come insostenibile.
Dopo l’assassinio del padre per mano della madre, la protagonista si aggrappa alla memoria paterna come unica fonte di senso.
Clitemnestra, la donna che l’ha messa al mondo, si trasforma nell’immagine da cui separarsi con forza. In questo gesto si concentra un dissido che molte donne, anche lontane dal mito, conoscono intimamente: la difficoltà a riconoscere nella madre un’identità praticabile, una presenza con cui costruire un dialogo. Non c’è più un soggetto con cui confrontarsi, ma un bersaglio da attaccare. E quando la relazione si riduce a questo, ogni possibilità di trasformazione si blocca.
Jung individuava in quest’ultima l’archetipo della figlia legata al padre, ostile alla madre, alla ricerca di un modello maschile con cui riconoscersi.
Ma la posta in gioco è più complessa. Il rifiuto della madre, più che una scelta consapevole, è spesso la conseguenza di una percezione di tradimento primario. Clitemnestra non è solo l’assassina del padre, è la figura che interrompe la fiducia, che spezza la continuità dell’universo affettivo.
L’identità della figlia si costruisce allora su una scissione: un legame perduto che non riesce a diventare simbolico.
Nel rapporto madre-figlia si annodano forze ambivalenti: da un lato il desiderio di somiglianza, di riconoscimento, dall’altro il bisogno di differenziarsi, di affermarsi come soggetto autonomo. Ma quando la madre è vissuta come indegna o distante, questa tensione non genera crescita, ma rottura. La madre non è più interlocutrice, ma antagonista.
Questo conflitto – reale o fantasmatico – può abitare a lungo la psiche femminile, lasciando un’eredità difficile da elaborare.
Molte narrazioni contemporanee, letterarie e cliniche, ruotano attorno a questa ferita.
Modelli materni percepiti come inaccessibili, giudicanti o fragili abitano i ricordi e le parole di chi, diventando adulta, cerca ancora uno spazio in cui essere vista, riconosciuta, accolta. Il contrasto non è sempre manifesto: talvolta prende la forma dell’imitazione forzata, altre volte della negazione totale.
Il fulcro della questione è uno come si diventa donne se il primo specchio è incrinato?
Il mito non offre risposte, ma espone la domanda.
In Elettra non c’è pacificazione, non c’è sintesi. La vendetta non ricompone il legame, lo cancella.
In questo, il mito ci mette davanti alla conseguenza estrema di una relazione madre-figlia che non ha potuto essere abitata come spazio relazionale, bensì in quanto campo di battaglia.
La psicoanalisi, invece, apre un altro varco.
Permette di distinguere la madre reale da quella interiorizzata, di restituire sfumature a ciò che è stato vissuto in bianco e nero.
Il lavoro psichico sul materno è spesso silenzioso, lungo e stratificato, ma necessario.
Perché solo riconoscendo leambiguità si può disinnescare il potere persecutorio dell’immagine materna.
Solo così è possibile trasformare il rifiuto in narrazione, e la ferita in storia condivisibile.
Il mito, con la sua forza immaginativa, ci aiuta a pensare ciò che le parole ordinarie non sanno dire. In Elettra, ritroviamo l’eco di domande che restano attuali: É possibile essere figlia senza negare la madre? Cosa accade, dentro di noi, quando quel legame si rompe troppo presto o non nasce affatto?
Riferimenti bibliografici:
- C.G. Jung, Tipi psicologici, Bollati Boringhieri, 1991
- Erich Neumann, La psicologia del femminile, Astrolabio, 1977
- Julia Kristeva, Storie d’amore, Raffaello Cortina, 2000
- Eschilo, Le Coefore, a cura di Guido Paduano, BUR, 2008
Mara Cozzoli