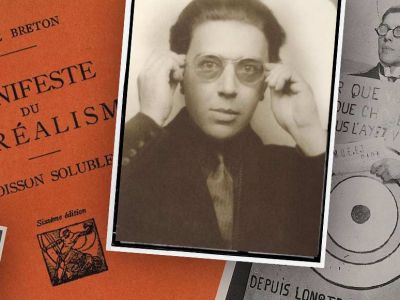Uno sguardo sul mondo. Intervista a Ugo Panella, fotogiornalista.
Quando le parole risultano incomprensibili, allora, subentrano le immagini, pronte a demolire muri, scatti immobili ma immensamente forti, in grado di mostrare lo scorrere veloce del tempo, sempre in prima linea, al fine di donare reputazione a chi non taglia il traguardo, agli invisibili , agli ultimi delle classe.
Sono anime trafitte dalla fragilità del mondo, vicine o distanti da noi, sfiorano le nostre vite e i nostri occhi, i quali, spesso, bassi innanzi ad esse, cercano di alzare barriere difensive.
Oscillando tra passato e presente, dialogo, oggi, con Ugo Panella.
Ci racconti qualcosa di lei, magari a partire dagli anni ’70 quando diede inizio alla sua attività di fotogiornalista.
Era la fine degli anni ’70 e i conflitti, allora, erano concentrati in centro America, soprattutto, in Nicaragua, Salvador e Guatemala: i fatti politici, per buona parte di quel periodo e per tutti gli anni ’80, accadevano lì, salvo poi spostarsi al Sud. Avevo la passione, non tanto per la fotografia, perché quest’ultima è stata un mezzo per poter raccontare, ma per la storia e i fatti politici internazionali. Del resto, arrivavo dalle immagini della guerra del Vietnam e avevo capito che la fotografia era dotata di una sintesi che neanche la parola scritta o un video possedevano.
Sono partito, così, per il Nicaragua per testimoniare i conflitti intercorrenti tra Contras e Sandinisti; questi ultimi, poco tempo prima, avevano vinto la rivoluzione, cacciando Somoza, dittatore che governò per trent’anni.
Subito dopo, si aprii una controguerriglia: io ho seguito tutti quegli avvenimenti politici, poi, mi sono trasferito in Salvador dove la guerra civile durò per altri dieci anni.
Quindi, nel suo lungo girovagare si è interfacciato con culture differenti…
Beh, sì… dopo il Centro America e il Sud America, mi sono trasferito in Africa, muovendomi tra Sierra Leone, Somalia ed Etiopia.
Inoltre, mi sono immerso in Medio Oriente, lavorando in Iraq e Afghanistan, tra l’altro, quest’ultimo è il Paese in cui mi sono mosso più a lungo.
Ormai, sono anni che mi ci reco e ho attraversato tutti i vari regimi che si sono susseguiti.

Come funzionava e come funziona ora il fotogiornalismo?
Per fortuna, a quei tempi, i giornali compravano le foto e producevano servizi, cosa che, oggi giorno, è assolutamente impossibile fare.
Negli ultimi trent’anni la società è caduta in stato di degrado portando immagine, fotogiornalismo e giornalismo a subire la stessa sorte: si sono ridotti gli investimenti e i canali televisivi sono aumentati a dismisura, per cui i giornalisti sono diventati coloro che suonano ai citofoni per capire lo stato d’animo di colui a cui hanno ammazzato la madre.
Non si può fare di tutta l’erba un fascio, ma la qualità del settore negli ultimi quarant’anni è scaduta.

Un mese fa è tornato dall’Afghanistan, la stampa non ne parla più. Quale situazione ha trovato?
I giornali parlano delle cose che in quel momento vanno, successivamente, tutto cade nel dimenticatoio. Lo scorso anno, in agosto, dopo il ritorno dei talebani, tutti parlavano dell’Afghanistan, poi, improvvisamente, più niente… è arrivata l’Ucraina che ha soppiantato l’Afghanistan..
E che ha scansato anche al Covid..
Infatti, questo è l’andamento del giornalismo, occorre sottolineare che in Afghanistan, adesso, non c’è più nessuno.
Io sono andato con Fondazione Pangea, che si occupa di micro credito per le donne.. con l’avvento dei talebani, questi progetti in favore del sesso femminile sono saltati.
Siamo tornati per modificare tali propositi e ho visto un Paese completamente allo sbando e in piena emergenza alimentare. Più del 90% della popolazione sta letteralmente morendo di fame: famiglie che vendono figli, salvando loro la vita e riuscendo, in tal modo, a campare essi stessi, ovviamente finché i soldi non finiscono, c’è chi vende il rene per poter andare avanti. La situazione delle donne è tornata indietro di vent’anni: ora, le bambine non possono studiare oltre i dieci anni, oltretutto, le donne non possono più lavorare. In sintesi: l’orologio della storia è tornato indietro a prima del 2001. I talebani sappiamo essere andati al potere nel 1996 fino all’abbattimento delle Torri quando è avvenuta l’alleanza del Nord. Non vi erano giornalisti presenti in quel momento, del resto, non era remunerativo. Tutto ciò è frustrante per chi, come me, svolge questa professione.


Allora, parliamo della componente emotiva legata alla sua attività.
Ho visto conflitti e mi sono occupato di quelli che definisco i “sotterranei dell’umanità”. Insieme a Renata Pisu, ad esempio, quando era inviata esteri di Repubblica in Bangladesh, ci siamo occupati delle ragazze sfigurate dall’acido. In quel periodo, anche io, lavoravo per D di Repubblica, la quale mandava inviati e si aveva il tempo necessario per fare ciò che eravamo chiamati a fare. Deve sapere che si lavorava in analogico e tutte le spese erano a carico loro, gli inviati venivano pagati abbastanza bene e veniva fuori un lavoro di dodici / quattordici pagine. Ad ora se ti pubblicano due fotografie te le pagano venti euro, insomma, non è un pagare, ma un’elemosina priva di consistenza. I rari servizi che si vedono sui giornali, ad ora, sono presi da agenzie fotografiche: una foto di qua, una foto di là, senza nessun costrutto e, i giornalisti, crescono stando davanti al computer senza avere la possibilità di conoscere gli avvenimenti stando sul campo.
Basta guardare alcuni reportage sull’Ucraina, alcuni di questi sono ridicoli. Mantengono persone sul posto con giubbotti ed elmetti riportanti la scritta “Press”, dopo di ché, vivono in albergo, escono dall’albergo si fanno riprendere e raccontano qualcosa…in realtà non si recano né in prima linea, né dalla parte russa. Fanno quel servizio che serve al canale per dire: “CI siamo anche noi”.


Tutto ciò, secondo lei, può essere equiparato a una mossa marketing?
Sicuramente, c’è la volontà di sostenere una parte piuttosto che l’altra, condizionare in un modo o nell’altro l’opinione pubblica. Non può registrare le guerre da una sola parte se vuole capire quanto sta accadendo anche se, comprendere è difficile, soprattutto, adesso, dato l’intersecarsi di tante variabili che prima non c’erano.
La guerra la fa, in particolar modo, l’informazione, l’ufficio stampa dei vari eserciti.

Lei è stato anche in Ucraina: come vede questo conflitto? Qual è la situazione reale?
Premetto che non ho fatto la parte della guerra, mi sono recato in Ucraina perché da anni affianco Fondazione SoleTerre Onlus che si occupa di oncologia pediatrica. Misi la prima volta piede a Kiev nel 2009, appunto per entrare in oncologia pediatrica dove erano ricoverati bambini con patologie tumorali, partoriti da donne contaminate dopo lo scoppio della centrale di Chernobyl e ci ho lavorato per circa un anno e mezzo, alla fine, abbiamo anche organizzato una mostra a Palazzo della Cultura di Kiev.
CI sono ritornato perché molti bambini malati sono stati evacuati dagli ospedali di Kiev e Leopoli per essere portati in Italia: dato lo stato di guerra, vi è mancanza di medicinali e, per quelli più gravi, possibilità di assistenza. Dunque, ho fatto da spola tra Leopoli e l’Italia, frequentando e documentando i centri d’accoglienza in Polonia, gettando lo sguardo su questi disperati che arrivavano dalla frontiera di Medika, ospitati in centri commerciali in cui hanno trovato la giusta assistenza medica e alimentare, vi sostavano, due o tre giorni nell’attesa di venire, poi, smistati nelle nazioni da loro scelte.
Questo conflitto parte da lontano.
Gli uffici stampa equiparano l’Ucraina a un Paese virtuoso quando, secondo la mia esperienza, è un Paese governato per tanti anni da oligarchi e mafiosi.

Esatto, su questo punto mi ha anticipato.
Improvvisamente, tutto è cambiato. Va aggiunto che, nel 2015, quando il Donbass, di cui nessuno sapeva nulla, chiese l’indipendenza dall’Ucraina, quest’ultima non accettò e gli mandò l’esercito: ci furono oltre quindicimila morti e il divieto di parlare russo. Quindi, i fatti, vanno guardati da ambo le parti. Tale belligeranza fa comodo a tutti: a Putin per tutto ciò che sappiamo, a Zelensky perché, comunque, ha dato visibilità internazionale al suo Paese di cui, prima, nessuno si occupava, la ricostruzione dei Paesi distrutti sarà a carico dell’Occidente, lui diverrà eroe nazionale e si garantirà il potere per almeno vent’anni. Funziona per Biden perché avere un Europa in crisi e destabilizzata, giova all’economia americana. È una guerra che non solo andrà avanti molto tempo, ma ha fatto comodo a tutti coloro che, attualmente, sono i contendenti. Ecco, questa è la mia visione. C’è da dire che sia l’esercito russo che quello ucraino hanno proibito a tutti i mezzi stampa di andare in prima linea: nessuno si può spingere oltre qualcosa, sono già coraggiosi quelli che si spingono nelle zone più martoriate.
È una guerra che si gioca sulle posizioni e la propaganda ha fatto molto.
La stessa Polonia che, un minuto dopo, ha aperto le porte a tutti i profughi, sei mesi prima ha alzato i muri ad afghani e siriani lasciandoli in mezzo alla neve senza scarpe affinché non entrassero. Gli ucraini, di contro, sono stati subito accolti come fratelli. Dal canto mio, occorrerebbe vedere le cose senza il fanatismo di dire: tutto è bianco o nero. Non si può più guardare il mondo in modo manicheo perché quest’ultimo è sempre più complesso, le variabili sono sempre di più, conseguentemente, essere informato su tutto è sempre difficile: uscire dalla propaganda, per avere una visione d’insieme e obiettiva è, dunque, utopia.

Tornando al discorso Bangladesh, lei ha immortalato donne sfregiate dall’acido, una violenza fisica e psicologica allo stesso tempo. Come è riuscito a digerire, se è riuscito, quanto aveva innanzi agli occhi?
Ti dirò che è più facile digerire una guerra che queste circostanza. Se vai nella zona di conflitto e vedi morti in terra (lo dico in modo cinico), fanno parte del paesaggio. Avere affrontato un tale lavoro che, in un primo momento, è durato quasi un mese (reportage per Repubblica), quando poi sono tornato l’anno dopo per farne il libro “Volti negati”, ammetto la difficoltà nel sopportare che ragazze, quasi bambine, perché hanno tredici, quattordici anni vengano distrutte per sempre e, quelle fortunate, secondo me, sono quelle morte, perché, almeno, non hanno più dolore, non devono sopportare una slavina di sofferenza inimmaginabile. Ecco, vederle distrutte, semplicemente perché non hanno aderito a un matrimonio combinato o hanno denunciato uno stupro e, quindi, vittime della violenza degli uomini. In un primo momento l’impatto non è stato felice, poi, onestamente, dopo tanti mesi passati insieme a loro, che inseguito mi hanno accompagnato nei villaggi per farmi conoscere quelle sepolte dalle famiglie che si vergognano di avere questo problema in casa e, dunque, uccise due volte, da chi le ha ridotte così e dai parenti che le tengono nascoste a vita, alla fine, mi sono trovato, talmente tanto, inserito nella storia che non le ho più viste come ragazze sfregiate, ma come persone normali.. a forza di starci insieme, non ho più visto le offese, dopo tanti mesi si è creato, anche un rapporto d’amicizia. Il vantaggio di questo lavoro è stato che, non appena uscito in Italia, ha fatto il giro del mondo ed è stato pubblicato anche dal Times, l’opinione pubblica è stata, finalmente, mossa: una bolla d’aria è scoppiata e tutti sono venuti a conoscenza di quanto stava accadendo, ovvero che circa ventiduemila ragazze ogni anno subivano quella sorte: in conclusione, quaranta di esse sono state portate in altre parti del mondo per essere curate (quelle che potevano esserlo). È stato un reportage che, due anni dopo, ha condotto il Governo del Bangladesh ad immettere la pena di morte nel suo ordinamento giuridico, ovviamente, non è mai stata applicata, ma sul piano formale, quanto fatto, ha costretto, sotto la pressione della comunità internazionale, a fare un passo importante. La fotografia non cambia il mondo, ma certe volte, casualmente, può migliorare la condizione di tante persone o aprire gli occhi su certe realtà che, altrimenti, rimarrebbero sommerse.

Inizialmente, com’ è riuscito ad approcciare con queste ragazze? Suppongo non sia stato semplice, penso alla loro paura, al loro diffidare. Come ha conquistato la loro fiducia?
Sai, il destino.. non conoscevamo questa situazione, ci trovavamo lì per caso: dovevamo fare altro, un reportage sullo smantellamento delle navi cargo a Chittagong, porto al confine con la Birmania. A metterci a conoscenza di questa condizione è stata Laura Gragnani che, in quel periodo, lavorava per la Comunità Europea: ci siamo attivati, subito.
Loro erano protette da un’organizzazione locale e, il fatto che io fossi uomo mi aveva penalizzato, fossi stato una fotografa, sarebbe stato più semplice. Per avere il consenso è stata molto brava Renata Pisu che, data la sua esperienza e il suo essere donna, è riuscita a convincere che il nostro intento non era sbattere il mostro in prima pagina, ma dare un aiuto., come poi è stato.
Per ottenere l’autorizzazione, abbiamo impiegato due settimane: pensa, in precedenza, avevano rifiutato la CNN che in modo aggressivo aveva chiesto dodici acidificate per il giorno successivo…come se stessero facendo un ordine al ristorante: questo tipo di approccio è stato rifiutato, inevitabilmente, ha disturbato.
Il nostro progetto così, fortunatamente, è stato approvato.

Passiamo ai malati di mente incatenati, immagini molto forti che inducono a riflettere senza sfociare nel senso di pietà.
Anche qui il caso ha dato origine a tutto. Ero andato con Luca Castello, giornalista, anch’egli di Repubblica, a fare un servizio su una suora laica, Annalena Tonelli, uccisa l’anno dopo nel Somaliland, unica parte della Somalia indipendente ed ex colonia Britannica. La donna lavorava in ospedale a Boroma e curava gli incurabili: i malati di tisi e AIDS. Lei andava contro tutti e la conseguenza, fu, appunto, la sua uccisione da parte di alcune fazioni locali. Stando lì, ci siamo accorti di una struttura gestita da organizzazioni del posto. Da raccontare c’era poco: gente buttata per terra e incatenata a cerchioni dei camion con temperature che sfioravano i quarantacinque gradi tutti i giorni, l’aria era irrespirabile. Tutto era ristretto, circoscritto dentro un cortile con inferriate di ferro, come in galera, nel quale venivano introdotti i più violenti. Vi erano, inoltre, alcune tende, con persone, come detto poc’anzi, incatenate.

Altra realtà, spostiamoci in Italia. Lei ha realizzato un lungo reportage su un ospedale psichiatrico.
Sì, il Papa Giovanni XXIII a Serra D’Aiello in Calabria: la struttura, ad oggi, non esiste più.
Anni prima, per D di Repubblica, mi ero occupato di donne che, in Italia, si muovevano in campi eccezionali: tra di esse c’era colei che era stata il braccio destro di Franco Basaglia, nonché Assunta Signorelli che, dopo essere stata chiamata in questo cronicario per cercare di mettervi ordine, donando ai pazienti calore umano e relazioni, togliendo loro i farmaci con cui venivano storditi, ha deciso di contattarmi.
Due mesi dopo il suo arrivo in Calabria, l’ho raggiunta. Ci ho lavorato circa un anno, a più riprese.
Tutti i giorni, mi muovevo per i diversi reparti e ne è uscito un libro, di cui ho mutuato il titolo da un verso di una canzone di De Andrè: “In direzione ostinata e contraria”.
Ho dovuto aspettare sei mesi prima di avere l’autorizzazione ad utilizzare il titolo, che mi è arrivato, poi, non solo da Fondazione De André, Dori Ghezzi, ma anche da Ivano Fossati e dall’editore musicale che ha progettato il disco. Dal libro è sorta una mostra itinerante.
Per un anno ho vissuto la malattia mentale nelle sue differenti forme; molti di loro erano stati abbandonati dalle famiglie, rinchiusi in questo luogo, depositati senza essere assolutamente matti, ovviamente lo sono diventati con il tempo, date le condizioni.

È tipico… anzi, quanto mi sta dicendo, ricorda i dieci giorni in manicomio di Nellie Bly.
Sì la gente entra in un certo modo poi, lasciata a se stessa, nel corso degli anni, assimila dall’ambiente che vive. Ricordo che il sabato era giorno di visita, non passava nessuno: in tanti mesi che sono rimasto, si è presentata un solo parente per lasciare un pacco, dei vestiti. Persone, abbandonate a se stesse e curate con medicinali che li tenevano più o meno sonnolenti e buoni.

Mi sta raccontando una realtà che fa specie, a maggior ragione, se pensiamo che la Legge Basaglia risale al 1978.
È una realtà di dieci anni fa, non attualissima, ma ci siamo. Quello che volevo far capire è che i buchi neri non sono solo lontani da noi. La gente innanzi alla malattia mentale è più spaventata che davanti a quella fisica.

Lo so, ed è uno dei motivi per cui ho scelto di raccontare il disagio psichico. Davanti alla malattia mentale si cerca di “proteggersi” perché ci si trova difronte a qualcosa che, all’apparenza, non ha una motivazione razionale…se scavi nel profondo, però, una motivazione esiste. In realtà, si ammala il corpo e si ammala la psiche, la differenza è che per quest’ultima non esiste una guarigione nell’esatto significato del termine.
Penso faccia parte di un mondo che è sconosciuto e che non si può penetrare. Dopo avere lavorato a questo progetto ho fatto una sintesi, che fa capire come non ci si capisca niente: “Un cancello, un cortile, ombre e silenzio. Gregorio mi passa avanti con troppa fretta, trasporta la sua vita interrotta in luoghi senza nome, in fuga da un destino che la mente non riesce a sopportare. Le certezze cambiano all’orizzonte e le parole pretendono un alfabeto diverso da quello conosciuto. Gesti semplici per un incontro che non vuole imbarazzo. Mi costringo a guardare lontano dove la mente vuole un finale diverso, lontano dai miei pregiudizi. Ho vissuto lunghi giorni con uomini e donne che cercavano attenzione. Affidandomi a gesti nuovi li ho ascoltati, prima ancora di cogliere in uno scatto i loro sogni invisibili. Ho sentito grida scomposte, respirato odori forti e visto in tanti occhi la rabbia muta di chi cerca comprensione, ma quel confine è rimasto confine”.
Sai, alla fine, nonostante le ore trascorse con loro, non ho capito nulla. Pensare di entrare nell’universo della mente di queste persone è utopia, presunzione.

Questo è vero, in realtà c’è da dire che la bellezza della psiche risiede in questo: lei è fortissima, ma allo stesso tempo è fragile.. occorrerebbe trovare un minimo di equilibrio tra le due componenti. Penso sia affascinante.
Esatto e chi ci lavora dentro ha più strumenti per capirlo, ma dato che non ho questi codici e basandomi su quanto vedevo e sul contatto umano, personalmente li ho ascoltati, guardati e dato loro la comprensione che chiedevano, la comprensione umana, non ho fatto finta di capire.
Rispondere al perché sono lì, è compito dei tecnici, lei però ha trovato la giusta chiave di lettura: comprensione e riconoscimento in quanto persone.
Comunque, andiamo avanti. In che modo il suo girovagare tra luoghi e culture differenti hanno influenzato lo sguardo con la quale osserva il mondo?
Ha influenzato parecchio perché lavorando in contesti di emarginazione e difficoltà di vita ho imparato sottrarre anziché addizionare, ho compreso che le cose fondamentali sono due e non duecento e che la nostra cultura, soprattutto quella consumistica, ci contorna di inutilità e ci offusca la vista.
Sottrarre è anche il ruolo della fotografia, perché la fotografia è sintesi, ovvero la sottrazione dell’inutilità per lasciare spazio a ciò che dona senso a quanto stai guardando. Queste esperienze mi hanno tolto tutti gli orpelli che sembravano importanti, quasi indispensabili che, in fondo non servono, e di cui la gente si sommerge, spesso, incasinandosi. Ho rinunciato a tante cose materiali e la mia vita si è semplificata.
Ho tolto ciò che ho reputato sterile e questo vale per cose e persone. Sai, mi sono calato in mondi che non mi appartengono, situazioni in cui, nonostante tutto, risulto straniero e, quando torno, coloro che mi circondano e che di queste situazioni non ne vogliono sapere, mi portano ad essere straniero anche in casa mia. Condividere queste esperienze con chi non può capirle, mi rende solo e straniero, ovunque.

Quanto mi sta dicendo si evince anche dal fatto che ha scelto di puntare il suo obiettivo verso gli invisibili.
Quando avevo sedici anni, mi ero innamorato di Fabrizio De André che, attraverso le sue canzoni mi diceva cose diverse dalla società in cui vivevo o dalla scuola che frequentavo. In poche parole, il cantautore mi ha indicato una strada…lui raccontava, sostanzialmente, gli ultimi, persone messe al margine dalla società ben pensante a cui restituiva dignità: che fossero drogati o prostitute. Ciò mi affascinò a tal punto, che vissi Fabrizio, non tanto come cantante che aveva tutto per essere amato, ma soprattutto per i suoi testi. Mi ha raccontato strade che poi ho percorso, perché quanto lui narrava con le parole, ho cercato, poi, di raccontarlo con le immagini.
Spesso, mi reco nelle scuole e ai ragazzi, attraverso i miei scatti, mostro storie di prostitute bambine, ragazze sfigurate dall’acido, amputati della Sierra Leone.. tutte situazioni che partono da gente che fatica la vita, che non ha benessere e, a volte, neanche speranza futura. De André accendeva i riflettori su chi perdeva, non su chi vinceva. Fondamentale nello svolgimento della mia professione è stato leggere, leggere molto. Prima di partire per i miei reportage, di quel Paese studiavo la letteratura, la politica e l’economia. Cercavo di mettere insieme più tessere possibili.

Se posso permettermi, si vede, è chiaro. Le sue sono immagini che, veramente, restituiscono dignità all’uomo almeno, io ho colto questo.
Ma, tra tutti gli scatti, ce n’è uno che le è rimasto maggiormente nel cuore o che, ha lasciato un segno particolare nella sua vita?
Ce ne sono tanti, perché, alla fine, gli scatti rappresentano momenti di vita vissuta. Poi, ci sono Paesi a cui sono maggiormente legato. Potrei dirti lo scatto in Nicaragua, che simboleggia l’inizio del mio lavoro. Ho vissuto quindici giorni nella giungla con i Sandinisti e, posso indicarti la foto relativa all’attimo di riposo con loro, c’è anche quella che ho eseguito in Sierra Leone con un padre che abbraccia una bambina: la piccola è stata costretta a tagliare il braccio del suo papà. Durante la guerra civile per i diamanti, i guerriglieri del Ruf entrarono nel villaggio presero la bambina e, dopo averle puntato un kalashnicov alla nuca, le misero un macete in mano obbligandola a tagliare il braccio del padre, il quale mi disse: “Almeno la posso vedere crescere e abbracciare”. Sono foto simbolo, insomma, a ricordare attimi particolari.

Percepisce mai il senso di pericolo?
Sì, parecchie volte, anzi, meno male che lo percepisco: ti salva. In Somalia e ad Haiti sono stato picchiato. Chi svolge questo lavoro si trova sempre in situazioni estreme e di aggressività con variabili che puoi controllare fino a un certo punto. Il senso del pericolo devi averlo, altrimenti, ti metti maggiormente a rischio, c’è un termine tecnico che si chiama “Geografia del pericolo” che devi saper valutare e con l’esperienza lo fai, però c’è sempre un margine nel quale non puoi entrare, una zona d’ombra che non puoi controllare: le situazioni sono diverse, i luoghi sono diversi e differente è, non solo la gente, ma ciò che essa vede in te.
All’interno di questa zona d’ombra, come riesce a mantenere un minimo di lucidità?
La cosa importante, soprattutto, in situazioni di conflitto, è mantenere non solo lucidità, ma anche saper gestire lo stress… la fotografia avviene dopo, se non riesci a fare questo, non potrai fare una fotografia.
In una delle ultime foto che ho fatto sugli eroinomani in una zona di Kabul, sotto un cavalcavia, dove erano ammassati come topi centinaia di uomini, per potervi andare, prima di tutto, ho dovuto gestire la paura perché può capitare di tutto, infatti, dopo un’ora, due pusher ci hanno minacciato con una siringa e se ti pungono, hai buone probabilità di prenderti l’AIDS. Prima di scattare, devi essere sicuro di quello che fai e non avere paura, la paura, sotto sotto ce l’hai, però devi controllarla, altrimenti non fai un passo: immagina a quale inferno andrebbe incontro?

Mara Cozzoli