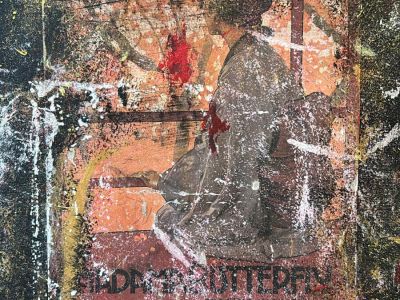Monza, l’assessora alla Cultura Arianna Bettin: “Diamo spazio ai giovani per cambiare la realtà”
Arianna Bettin è una delle amministratrici più giovani della città di Monza, oggi assessora alla Cultura.
La sua esperienza nasce da un impegno civico precoce, iniziato tra i banchi di scuola e poi consolidato nella vita politica cittadina. In questa intervista racconta il suo percorso, il rapporto con i giovani, il ruolo della cultura e le sfide di una politica che deve imparare a comunicare in modo nuovo, senza rinunciare alla profondità dei contenuti.
Lei è una delle più giovani amministratrici di Monza. Cosa l’ha spinta a entrare in politica?
Il mio interesse nasce da lontano, già ai tempi del liceo. Ho poi deciso di iscrivermi a una giovanile di partito. Mi spingeva un forte senso di ingiustizia per ciò che in quegli anni accadeva in Italia. Limitarmi a leggere i giornali o guardare la TV non mi bastava: ho sentito il bisogno di partecipare in prima persona, come dovere civico. Sono convinta che le cose possano cambiare solo con l’impegno attivo, non con la lamentela. Ho iniziato così nelle giovanili, ma presto me ne sono allontanata. Nel 2016, a 21 anni, sono stata tra i fondatori della lista civica con cui poi sono stata eletta. In sintesi: dai 14-15 anni ai 20 ho vissuto un percorso di formazione che mi ha portata a impegnarmi in prima linea.
Cosa significa svolgere questo ruolo in una città come Monza?
Per noi, con la nostra lista civica, ha voluto dire ricostruire un legame con le tante anime della città, raccogliendo istanze dal basso e provando a esserne portavoce. Una volta entrati in amministrazione, però, la complessità è aumentata: Monza, terza città della Lombardia dopo Milano e Brescia, ha dimensioni significative, ma conserva dinamiche ancora provinciali. In questa tensione non è semplice muoversi. Non si può rappresentare solo una parte: occorre allargare lo sguardo, cercare equilibrio tra sensibilità personali e quelle di un tessuto cittadino con caratteristiche specifiche. Inoltre, la macchina amministrativa di una città media come Monza non è piccola abbastanza per essere gestita con poche risorse, né grande quanto Milano, dove ogni assessore ha uno staff ampio. È una dimensione che impone ostacoli, ma col tempo si imparano le giuste strade da percorrere.
La sua giovane età l’ha mai fatta sentire sottovalutata?
All’inizio, al momento della nomina, meno.
Durante la campagna elettorale, invece, sì. Non solo perché ero giovane, ma anche perché facevo parte di una realtà politica composta in larga parte da giovani. Ottenere rispetto non è stato facile, e tuttora riceviamo critiche che oscillano tra l’accusa di ingenuità e il paternalismo. Personalmente non mi sono mai sentita svalutata per l’età, semmai un po’ di più per il fatto di essere donna.
Come ha affrontato questa difficoltà legata all’essere donna in politica?
Spesso, oltre ai limiti che vengono dall’esterno, esistono limiti che agiscono più dentro di noi, limiti che abbiamo interiorizzato e su cui è indispensabile lavorare. Non ho incontrato forme manifeste di discriminazione, fortunatamente, ma ci sono segnali più o meno sottili che ti fanno sentire inferiore, che minano le tue sicurezze. C’è anche la sindrome dell’impostore, che colpisce più le donne che gli uomini. Ho lavorato molto su me stessa, cercando di capire che certe insicurezze non derivavano da miei difetti, ma dal contesto in cui entravo: donna, giovane, alla prima esperienza. Questa consapevolezza mi ha dato forza. Il femminismo, praticato, ci insegna a decostruire logiche interiorizzate. Smontarle poco a poco mi ha aiutato a conquistare più sicurezza e affrontare situazioni che qualche anno fa mi avrebbero messo in difficoltà.
I giovani vengono spesso descritti come distanti dalla politica. Lei cosa ne pensa?
Credo sia una distanza solo apparente: si tengono lontani dalla politica istituzionale, ma non significa che non se ne interessino. Molti si appassionano, ma non trovano spazi dove sentirsi ascoltati alla pari. Noi siamo stati fortunati a creare un contesto in cui le voci giovani avevano dignità e un ruolo. Altrimenti capisco lo scetticismo: la politica di partito ha un’età media elevata, mentre quella istituzionale spesso non lascia spazio alla creatività dei ragazzi. Movimenti come Fridays for Future hanno mostrato sensibilità nuove, nate da altri canali. Il punto è che queste energie vanno intercettate, non con operazioni di facciata, ma dando ai giovani la possibilità di influenzare davvero politiche e programmi.
Quello che noto, anche seguendo i social, è che stanno emergendo nuove modalità e figure che parlano di politica e fanno informazione con strumenti diversi.
In questo i social giocano un ruolo decisivo?
Assolutamente sì. I ragazzi li usano con meno ingenuità degli adulti e hanno creato opinione. Penso ad esempio al femminismo: attraverso Instagram e altri canali si sono diffusi contenuti che hanno reso le nuove generazioni molto più consapevoli. Io stessa, che ho trent’anni, noto la differenza con i ventenni di oggi: loro hanno avuto accesso a riflessioni che io ho incontrato molto più tardi.
Quanto conta allora una comunicazione politica diretta e accessibile?
È fondamentale. Oggi non si guarda più la TV né si leggono i giornali come un tempo. Il rischio è scivolare nella banalizzazione, credendo che chi ascolta non abbia gli strumenti per capire. Una comunicazione chiara è importante, ma non bisogna sacrificare la profondità dei contenuti. Con i social il pericolo è l’appiattimento: video brevissimi, messaggi rapidi, poca complessità. La sfida è non semplificare ciò che non può essere semplificato.
Cultura e giovani: qual è il ponte possibile?
Credo che la cultura “imposta dall’alto” fatichi a interpretare le esigenze dei ragazzi. La scuola gioca un ruolo centrale, ma più avanti vedo difficoltà a riconoscere la politica, la cultura e le istituzioni come alleati. Rispetto al passato, i giovani hanno più difficoltà a costituirsi in associazioni, che restano invece uno strumento fondamentale per avere spazi e risorse. Oggi il panorama è frammentato: da un lato un’omologazione, dall’altro un’atomizzazione che rende rari gli spazi aggregativi.
A Monza esistono progetti pensati per valorizzare le proposte dei giovani?
Sì, e in particolare se ne occupa la collega Andreina Fumagalli, delegata alle politiche giovanili. Per quanto riguarda la cultura, ho cercato di creare piattaforme soprattutto nell’ambito musicale.
Il Live Sound Festival, ad esempio, ha offerto spazi a giovani band in una fase in cui i locali erano in crisi dopo il Covid. Ho anche spinto affinché nei bandi dedicati alle associazioni culturali si desse attenzione a un pubblico giovanile e che iniziative già esistenti – vedi il Festival del Parco – aprissero di più ai ragazzi.
Per concludere: qual è la sua riflessione finale sulle nuove generazioni?
Sono molto critica verso chi tende a denigrare i giovani. Al contrario, ripongo in loro una grande speranza. Penso a Greta Thunberg e al movimento che ha saputo guidare: hanno costretto la politica a guardare al tema del cambiamento climatico. I nostri ragazzi hanno davvero qualcosa da dire. Gli adulti dovrebbero aiutarli a farlo senza tarpare le ali
Sono generazioni educate, poco trasgressive: magari cantano ciò che non condividiamo, ma raramente mettono davvero in discussione il sistema.
Eppure è proprio la ribellione ad aver sempre spinto avanti la società. Gli adulti dovrebbero lasciare spazio anche a questo, per vedere quali frutti potrà generare.
Mara Cozzoli