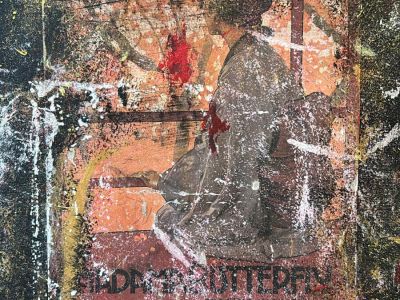Il “Modello Albania” al vaglio del diritto
Nel grande teatro della politica, alcuni atti si impongono per l’enfasi con cui vengono messi in scena, più che per la loro sostanza. Il “modello Albania” è stato presentato come l’esito audace di una strategia risolutiva: contenere i flussi migratori, spostare le frontiere, sottrarsi agli obblighi. Una narrazione muscolare, in cui la fermezza prendeva il posto del dubbio e l’azione sostituiva la riflessione.
Ma il diritto, a differenza della propaganda, ha un altro passo. E la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con una pronuncia ferma e argomentata, ha riportato l’equilibrio laddove il clamore rischiava di sommergere la norma.
La sentenza smonta le fondamenta giuridiche su cui si reggeva l’accordo: un Paese non può essere definito “sicuro” per decreto, senza una legge chiara, motivata e sottoposta a controllo giurisdizionale. Ogni designazione deve poggiare su criteri oggettivi, verificabili, e garantire una valutazione individuale, un contraddittorio e, successivamente, l’ impugnazione. Tradotto: non si gioca con le definizioni, quando in ballo ci sono vite umane.
Questa posizione non è nuova, ma affonda le sue radici in una visione del diritto che non è solo regola, ma coscienza. È lo spirito dell’articolo 117 della nostra Costituzione, che riconosce come vincolanti i principi del diritto internazionale, in particolare quelli che tutelano i diritti fondamentali. Ignorarli significa non solo infrangere la legge, ma minare i pilastri stessi della convivenza democratica.
“Paese sicuro” è diventata, nel linguaggio politico, una formula magica.
Un’espressione che, una volta pronunciata, semplifica, cancella, riduce la complessità dell’esperienza umana a una pratica da archiviare. Ma una norma etica non si piega a scorciatoie.
Non basta l’etichetta per mutare la realtà.
Ad ogni persona deve essere attribuita la facoltà di dire: “Per me, quel Paese non è sicuro”, e di essere ascoltata davvero.
Eppure, l’approccio adottato finora va in direzione opposta.
Il Governo ha reso quelle liste inemendabili, costruendo su di esse il pilastro della cosiddetta “procedura accelerata”, un dispositivo che assomiglia più a una catena di montaggio che a un processo giuridico. In pochi giorni si decide il destino di chi fugge dalla guerra, dalla fame, dalla persecuzione. La richiesta d’asilo diventa un codice a barre. L’individuo, un fascicolo da smistare.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata esplicita: dinamiche che prevedono il rigetto automatico delle domande, senza garanzie minime, sono incompatibili con il diritto appunto dell’Unione.
Non è solo una questione di forma, ma di sostanza: senza ascolto, senza tempo, senza contraddittorio, il diritto d’asilo viene svuotato del suo significato profondo. Da strumento di tutela si trasforma in mezzo di esclusione.
È questa l’illusione dell’efficienza: credere che si possa fare giustizia più in fretta semplicemente eliminando ciò che la rende giusta. Ma la rapidità, se non accompagnata dal rispetto, rischia di diventare solo una scorciatoia verso l’ingiustizia.
Il “modello Albania” non è, dunque, solo un inciampo giuridico.
È il segno di un approccio che considera la legge morale un ostacolo da aggirare, non una bussola da seguire. E in questo approccio si annida qualcosa di più profondo: la tentazione di una politica che antepone l’effetto alla riflessione, la promessa alla verifica, la forza alla misura.
La risposta del Governo alla sentenza europea è stata, prevedibilmente, di chiusura. Invece di aprire uno spazio di confronto, si è preferito evocare lo spettro dell’ingerenza esterna, come se la giustizia — quella europea, ma anche quella costituzionale — fosse una minaccia da cui difendersi, e non una garanzia da rivendicare.
Eppure, la verità — ora che la maschera è caduta — è più semplice di quanto sembri: il “modello Albania” è costato molto, ha prodotto poco, e si reggeva su fondamenta fragili. Ora che la Corte ne ha smascherato le debolezze, resta solo una constatazione: non si può costruire una politica migratoria violando le regole dello Stato di diritto per inseguire un consenso effimero.
Questa sentenza, in fondo, non parla solo di migranti, ma di noi. Di che Paese vogliamo essere. Di come scegliamo di affrontare la complessità del nostro tempo. Di quanto siamo disposti a sacrificare — e cosa no — in nome della sicurezza, del controllo, del “fare presto”.
Non è sufficiente spostare le persone altrove per alleggerirsi la coscienza. Delegare i confini non significa averli protetti davvero.
Ogni scorciatoia giuridica lascia un vuoto che, prima o poi, chiede conto.
Mara Cozzoli