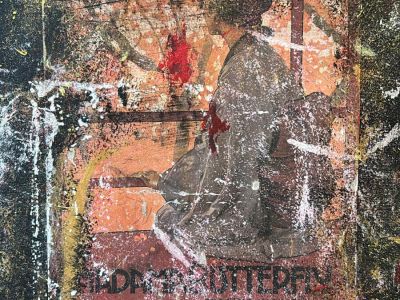La madre che uccide: Sindrome di Medea, il lato oscuro della maternità.
In Italia, i casi di figlicidio continuano a scuotere la coscienza collettiva, lasciando dietro di sé interrogativi irrisolti. In particolare, quando è la madre a uccidere, lo sconcerto può accompagnarsi al giudizio ed alla condanna e allora si possono leggere sulle cronache commenti con parole come “mostro” o “follia” e una forte spinta all’esclusione sociale. Ma cosa si cela davvero dietro questi gesti estremi? Che destino hanno le madri che si macchiano di un gesto così tragico da essere considerato come contro natura?
Dialogo, oggi, con Elisa Stefanati, psicologa e psicoterapeuta EMDR presso il Poliambulatorio Aesthe Medica di Ferrara e Milano, al fine di comprendere meglio il fenomeno noto come Sindrome di Medea, le sue radici psicologiche, le conseguenze relazionali e l’importanza di un approccio preventivo.
Un viaggio dentro l’ombra della maternità, con l’obiettivo di interrogarsi per comprendere e non semplicemente condannare.
Cos’è esattamente la “Sindrome di Medea” in ambito clinico?
La Sindrome di Medea non è una diagnosi riconosciuta o inserita nel DSM-5, il Manuale Diagnostico Statistico dei disturbi mentali, non è un termine clinico utilizzato dai professionisti della salute mentale per diagnosticare un disturbo specifico. Piuttosto, è una definizione che rimanda al Mito di Medea e Giasone, descrive -infatti- il comportamento di una madre che, in seguito a una separazione, tradimento, abbandono o un conflitto con il partner, arriva a compiere azioni estreme, talvolta anche l’infanticidio, come forma di vendetta o per danneggiare l’altro genitore. L’espressione è stata coniata dallo psicologo Jacobs nel 1988 per descrivere dinamiche figlicide strettamente connesse a separazioni fortemente conflittuali. In questi casi, il bambino viene “oggettivizzato” e trasformato in un’arma di vendetta strumentalizzata, un oggetto di contesa, per punire l’altro genitore.
Stacchiamoci, allora, solo per un istante dalla Sindrome di Medea. Delle madri che, invece, commettono figlicidio in generale, cosa può dirci?
Delle madri che commettono figlicidio, in generale, il profilo è stato ampiamente studiato. Non è infrequente trovare nella loro storia personale, fin dall’ infanzia storia di abuso e maltrattamento, ma spesso si rileva un’alta prevalenza di violenza domestica anche al momento dell’omicidio. Queste madri presentano una percentuale decisamente maggiore di disturbi psichiatrici, sia nell’anamnesi personale che familiare. Nell’anamnesi familiare non è infrequente trovare una malattia psichiatrica in uno o più familiari della madre, mentre rispetto all’anamnesi personale la letteratura è concorde nel riportare una precedente storia di malattia mentale. Nonostante le differenze i disturbi più frequenti sono senza dubbio quelli psicotici e quelli dell’umore, oltre a disturbi dell’adattamento, abuso o dipendenza da sostanze e ai disturbi di personalità. Il Figlicidio psicotico, comprende quelle madri che uccidono sotto l’influenza di un chiaro e grave disturbo psicopatologico, come una schizofrenia o una psicosi post-partum.
Ma il caso della sindrome di Medea merita una considerazione a parte.
Le azioni estreme e omicide verso un figlio, in questo caso sono guidate da un forte desiderio di vendetta e punizione nei confronti del partner. Queste azioni sono spesso legate a profonde ferite emotive, vissuti di abbandono, una visione distorta della genitorialità e del rapporto di coppia che correlano spesso con dipendenza affettiva, bassa autostima, isolamento e immaturità affettiva e mancanza di empatia.
Perché il tema dell’infanticidio è così difficile da affrontare anche nella comunicazione mediatica?
È un argomento ostico, che la cronaca spesso tratta in modo approssimativo, quando non superficiale. Parole come “mostruosità” o “aberrazione” dominano il racconto pubblico, mentre concetti come sofferenza, solitudine e disagio psichico restano sullo sfondo. È più rassicurante etichettare questi eventi come “follia” e prenderne le distanze. Ma la verità è che in molte situazioni la patologia non riguarda solo chi compie il gesto, ma anche l’ambiente familiare in cui l’atto nasce. La domanda fondamentale da porsi è: perché accade? E soprattutto, cosa possiamo fare per evitarlo?
Quali fattori ambientali e relazionali possono spingere una madre verso un gesto simile?
Ogni storia è unica, ma quasi mai il figlicidio è frutto di una sola causa. È il risultato di una costellazione di fattori: dalla salute mentale della madre alla qualità del rapporto con il partner, dal sostegno familiare disponibile alla presenza di traumi non elaborati. Spesso questi atti avvengono in contesti di coppia altamente conflittuali, dove il figlio diventa uno strumento di vendetta. Rabbia, solitudine, rifiuto, senso di esclusione: sono emozioni che, se non riconosciute, possono esplodere in modo devastante.
Quanto pesa la storia personale di una donna (traumi infantili, abusi, abbandono) nel rischio di sviluppare una tendenza figlicida?
Moltissimo. Tra le variabili troviamo:
Fattori individuali: età, livello di istruzione, salute mentale, esperienze traumatiche, legame con il figlio, capacità/incapacità di chiedere aiuto.
Contesto familiare: tipo di attaccamento con i genitori, eventuali gravidanze ravvicinate o indesiderate.
Variabili ambientali: precarietà economica, depressione post-partum, violenza ostetrica, mancanza di supporto da parte del partner o della famiglia.
Quanto incidono i modelli affettivi dell’infanzia nella genitorialità disfunzionale?
In modo determinante. Una madre infanticida può avere alle spalle un attaccamento disorganizzato con la propria madre. Questo però non significa che tutte le donne con vissuti traumatici diventino madri violente. È sempre il mix tra fattori biologici, esperienziali e ambientali a fare la differenza.
La maternità è spesso idealizzata. Quanto condiziona questa narrazione nel generare frustrazione o sofferenza post-partum?
Incide molto. Il mito della “madre perfetta” può diventare un boomerang. Ogni madre deve fare i conti con la realtà del bambino reale, spesso molto diversa da quella fantasticata. La nascita è anche un momento di separazione e perdita, e se non supportata, questa transizione può diventare destabilizzante. Il carico emotivo e fisico è enorme, e l’isolamento può aumentare il rischio di crollo.
Quali sono i segnali di sofferenza psicologica post-partum da non sottovalutare e che devono far pensare a segnali di “allarme”?
Alcuni segnali da monitorare: sbalzi d’umore marcati e persistenti, Pianto immotivato o eccessivo, aggressività, reazioni impulsive, e stati confusionali, Tendenze autolesive o comportamenti a rischio, Ritiro sociale, sensazione di fallimento, isolamento, assenza di legame con il bambino, conflitti di coppia e continue tensioni e asperità nella coppia,
Le madri non devono mai essere lasciate sole. Il benessere materno è il primo mattone della salute del bambino.
E quando è il padre a commettere il figlicidio? Cambia qualcosa nelle dinamiche?
Sì, nei padri il movente spesso è la gelosia o l’incapacità di accettare la separazione dalla partner. In molti casi si tratta di uomini con disturbi di personalità, comportamenti violenti pregressi, abuso di alcol. Il figlio diventa un “oggetto” della donna da colpire per punirla. Non di rado si assiste a tragedie familiari dove l’intero nucleo viene annientato per vendetta o senso di possesso. Anche qui, le radici affondano in un contesto relazionale disturbato e in una cultura del dominio e del controllo.
Quali emozioni può sperimentare una madre/Medea durante o subito dopo aver compiuto un atto così tragico?
Rabbia e odio profondo verso il partner o verso i figli perché visti come parte di lui; senso di potere come tentativo illusorio di controllo su una situazione vissuta come ingestibile come un abbandono o un tradimento da parte del partner; vendetta per ferire/distruggere l’altro genitore, disperazione, ambivalenza ove amore e odio convivono sullo stesso binario fino al gesto estremo; gelosia verso figli e partner ed infine possono emergere anche colpa e rimorso subito dopo l’atto con angoscia che tenta di giustificarlo.
Violenza e salute mentale vivono in stretta connessione.
Una riflessione va sempre fatta sul contesto di provenienza di ogni persona, madre o padre che sia.
Le manifestazioni di violenza all’interno della famiglia e nelle relazioni hanno molte manifestazioni che vanno dalla violenza psicologica, agli atti persecutori generalmente definiti col termine stalking, alle violenze fisiche e i soprusi o alla violenza sessuale. C’è una relazione strettissima tra violenza e salute mentale. Quando gli atti violenti avvengono davanti a minori, creano pericolosi fattori di rischio per la salute mentale I bambini assistono a circa il 90% degli episodi di violenza domestica e ne rimangono traumatizzati. I dati OMS rivelano che dove c’è violenza domestica raddoppia il rischio di maltrattamento e/o abuso sui minori da parte di chi l’agisce.
SI crede che basti inasprire le pene per evitare atti violenti. In realtà è necessario affrontare i problemi alla radice. Vorrei che spiegassimo l’importanza del riconoscimento delle emozioni e l’educazione affettiva a fini preventivi.
Risulta pertanto importante attivare interventi non solo sulle donne e sui minori, ma anche sugli autori di violenza di genere o maltrattamenti, basati su nuovi metodi di trattamento, con l’obiettivo di ridurre la recidiva e prevenire violenze future.
Non è dunque pensabile agire solo “dopo” un atto violento.
Vanno attivate politiche e progetti di prevenzione dei gesti estremi.
La rete si può costruire, bisogna solo cercare di intercettare prima e non dopo le segnalazioni ed educare le persone all’empatia e a non voltarsi dall’altra parte quando notano atteggiamenti preoccupanti, serve soprattutto un educazione dei sentimenti
E importantissimo sostenere progetti di sostegno psicologico, ed attivare programmi di intervento educativo rivolti alle madri nel tentativo di fornire loro informazioni sulla gravidanza, sul parto, sulla genitorialità, sulle cure e lo sviluppo del bambino sia rivolti alle madri che alle coppie di genitori.
Nella madre figlicida è possibile, a posteriori, la consapevolezza del gesto?
Si tratta di un lavoro molto complesso che deve poter procedere per fasi, è quindi difficile dare una risposta univoca ad una domanda così complessa. La valutazione va sempre fatta sul singolo caso. Innanzitutto il figlicidio è un evento estremamente traumatico, anche per il suo autore, quindi come per tutti i traumi, innanzitutto è bene procedere con cautela e gradualità. Non sempre la madre dopo tale gesto è consapevole del fatto commesso, potrebbe negarlo e rifiutare di averlo commesso. In altri casi, la persona potrebbe negare l’accaduto o minimizzarne la portata, specialmente se la sua capacità di elaborazione è compromessa da traumi pregressi o da disturbi mentali. E’ invece più probabile che la madre provi un senso di colpa o rimorso, ma la sua capacità di elaborare profondamente la situazione e di accettarne le conseguenze restino compromesse. Non è una reazione automatica o scontata, ma una possibilità che dipende da molti fattori, tra cui la gravità del trauma, le caratteristiche individuali della madre, il supporto ricevuto e il tipo di percorso psicologico intrapreso, il contesto di riferimento, il tipo di alleanza terapeutica che si struttura con il clinico ed il tipo di terapia. Gli obiettivi della terapia sono molteplici: esplorare e comprendere le motivazioni , emozioni e pensieri che hanno portato all’atto; ridurre la sofferenza emotiva per permettere di elaborare il trauma, insegnare alla persona nuove strategie adattive per affrontare le difficoltà emotive e relazionali, esplorare il mondo interiore per trovare nuovi significati alla vita, lavorare sulla prevenzione, per ridurre il rischio che si possano riverificare in futuro atti d’impulso, fornendo supporto e risorse alla persona ed alla sua famiglia
Mara Cozzoli