
Don Benito Giorgetta racconta “Passiamo all’altra riva”.
In “Passiamo all’altra riva” ultimo volume di don Benito Giorgetta con prefazione di Papa Francesco e post fazione di don Luigi Ciotti, fondatore di “Libera contro le mafie”, l’autore si interfaccia con Luigi Bonaventura, collaboratore di giustizia dal 2006 ed ex affiliato alla ‘Ndrangheta crotonese.
Il risultato è una testimonianza di vita che, infondo, si intreccia con la morte nelle svariate interpretazioni che ad essa possono essere date: morti in vita, morti che camminano, prigioni costituite da lugubri regole che strappano l’esistenza all’esistenza stessa e morti che rinascono, nonostante gli strascichi di un passato pesante.
La preziosità di queste centonovanta pagine è l’impostazione di un botta-risposta ricco di risvolti psicologici, sociologici, spirituali e giuridici in grado di indurre il lettore a riflessione.
Dialogo, oggi, con don Benito Giorgetta.
“Passiamo all’altra riva”, un titolo e un intrinseco messaggio. Cosa vuole insegnarci?
Ciascuno di noi, nel viaggio della propria vita, deve migliorare sé stesso. La vita è camminare verso un oltre in quanto durante il viaggio ci sono interruzioni, deviazioni, fatiche, cadute. Non dobbiamo mai scoraggiarci. Occorre essere uomini e donne di coraggio. Non dobbiamo abbatterci mai. Credo neppure rimproverarci, purché abbiamo dato il meglio e il massimo di noi stessi. Parlare di due rive non significa identificare una del bene e una del male. L’idea di navigare porta con sé che esistono, nella progettualità di ognuno, dei traguardi da raggiungere. Ecco l’altra riva è ciò che ci siamo prefissati di realizzare, di compiere. Allora passare all’altra riva è un’espressione esortativa. Di incoraggiamento. L’importante è che nessuno rimanga attraccato al porto delle sicurezze, delle convinzioni personali e per questo non intraprende mai il viaggio verso altri lidi, altre convinzioni. Passare è un verbo transitivo, un’esortazione a fare meglio, a fare di più. Riferita nel contesto del libro assume significati e sfumature un po’ più forti. Visto che si parla di mafia, di abbandono della mentalità mafiosa allora diventa una esortazione a lasciare certi stili comportamentali, certe ideologie ispirate alla sopraffazione, al sopruso, alla corruzione, all’illegalità, per andare verso la riva della legalità, dell’inclusione, dell’accoglienza reciproca, del rispetto di ogni persona, del perseguimento del bene comune nel rispetto delle regole e del convivere civile.
Al centro del suo lavoro la figura del collaboratore di giustizia, che, ancora oggi, spacca in due l’opinione pubblica. Da cosa ha origine, secondo lei, questa titubanza?
Credo che questa titubanza nasca dal fatto della diffidenza che si ha nelle figure dei collaboratori o testimoni di giustizia o dei denuncianti che dir si voglia. Chi sbaglia non deve rimanere seppellito dal proprio errore. A chi sbaglia gli si deve offrire la possibilità di riprovare. Il vasaio quando realizza un’opera se non gli riesce rimpasta tutto e ricomincia. “L’uomo non è il suo errore” (don Benzi). Nessuno deve annegare nel proprio errore. Ad ognuno dobbiamo dare una scialuppa di salvataggio. Dobbiamo imparare a dare fiducia a chi sbaglia dopo che riconosce il proprio errore. La dignità della persona umana non viene scalfita se non è onorata o rispettata. Una banconota se la sgualcisco, se la maltratto non perde il suo valore intrinseco. Un monile prezioso se viene schiacciato, appiattito non perde il suo valore. Perché se una persona sbaglia non ha più diritto di rimediare, di redimersi, di cambiare? La cultura del ravvedimento è un diritto pretenderla e un dovere praticarla. La mentalità comune, purtroppo, è efficientista. Si parla, amaramente, di scarti umani. Questa è una bestemmia vera e propria. La vita umana non va letta solo nell’ottica della produttività, dell’efficienza, dell’apparenza. C’è ben altro. C’è la persona umana che, anche se vecchia, a riposo lavorativo, anche se malata non cessa mai d’essere una risorsa per tutta la società. I denuncianti sono necessari a livello investigativo perché danno una grossa mano per stanare coloro che vivono di vendette, di odi, di rivalità, di soprusi, di coloro che della mentalità malavitosa ne hanno fatto il loro credo.

Raccontiamo, insieme, quanto queste persone sono importanti per la lotta contro la mafia, soffermandoci, anche sulla differenza rispetto al testimone di giustizia.
Solo chi proviene dal ventre della mafia conosce i segreti della mafia stessa. Essi sono come delle microspie, come delle telecamere che rivelano, portano a conoscenza. L’importante è capire questo: che i denuncianti non sono degli “infami” come li definiscono coloro che da essi vengono denunciati e scovati, messi a nudo, ma sono dei “coraggiosi” che, a rischio della propria vita e di quella dei familiari, fidandosi dello Stato, accettano la sua protezione in cambio di rivelazioni per giungere alle quali occorrerebbero anni di indagini, dispendio di forze, energie e risorse economiche. Senza dimenticare che con le loro denunce e testimonianze fanno recuperare beni allo stato che poi vengono restituiti alla fruizione della società civile. I beni così detti confiscati sono una grande risorsa sottratta alla malavita e restituita come ristoro alla società. Non dimentichiamoci che, per esempio, attraverso denunce e testimonianze si sono interrotti certi percorsi corruttivi, traffico di droga, soprusi e intimidazioni. In genere le persone che collaborano si definiscono collaboranti. Tra di essi c’è una distinzione tra collaboratori di giustizia e testimoni di giustizia. I primi danno informazioni ed offrono collaborazione per tanti episodi delittuosi, traffici illeciti, appalti truccati, infiltrazioni mafiose e altri crimini e delitti. I secondi denunciano chi li estorce oppure offrono la loro testimonianza per episodi singoli e circoscritti. L’importante è squarciare il muro omertoso e seminare la cultura della legalità, del rispetto delle leggi e degli impegni di ogni singolo cittadino. Si può essere anche collaboranti silenti ed operativi testimoniando la propria integrità morale e comportamentale. Basta chiedere la ricevuta al parrucchiere, al medico, al negoziante. Basta osservare la segnaletica stradale, è sufficiente osservare un retto comportamento in ogni circostanza della vita quotidiana. Anche questo è un modo “esemplare”, elegante, discreto, direi civile d’essere collaboranti.
Numericamente, tra collaboratori e testimoni di giustizia, familiari compresi, si raggiungono le 6000 unità. Quali sono le reali condizioni in cui sono costretti a vivere, perché molti di loro si autodefiniscono “Morti che camminano”.
Chi ha deciso di collaborare sa che ha messo a rischio la sua vita e quella dei suoi familiari i quali, molte volte ignari di tutto, all’improvviso, sono costretti a lasciare ogni cosa e trasferirsi in una località protetta con documenti ed identità così dette di copertura. Aderiscono e firmano un programma tra loro e lo Stato italiano ed entrano in un sistema di protezione che si prende cura di ogni loro necessità. Ricevono una casa il cui affitto paga il Ministero dell’Interno e ad essi viene corrisposto un rimborso mensile per le spese ordinarie. Oltre questo trattamento che sembra di riguardo, purtroppo hanno anche molti limiti sempre legati alla loro sicurezza personale. Non possono lavorare con un regolare contratto, non possono aprire un conto in banca e tante tante altre limitazioni. Se si debbono spostare per giuste ragioni debbono essere scortati. Molte volte vengono negati sacrosanti diritti di ogni libero cittadino perché sarebbe compromessa la loro incolumità e sicurezza. Talvolta neppure ai funerali dei genitori o dei figli possono prendere parte. C’è da dire che andando via dai loro luoghi lasciano tutte le loro proprietà che spesso vengono abbandonate a sé stesse. Nessuno andrebbe a comprare case o terre di persone che sono collaboranti in luoghi dove sono presenti coloro che essi hanno denunciato. La materia è molto complessa e delicata. Sarebbe diverso se appena avviene la collaborazione ad ognuno di venisse assegnata una nuova identità quella che si chiama cambio di generalità. Purtroppo una cosa molto brutta è che queste persone da chi li avversa o da chi non comprende la validità della loro collaborazione siano definite £parassiti dello Stato”. È falso e troppo ingeneroso e poco rispettoso, onestamente.

Il suo libro assume molteplici sfumature: psicologiche, sociologiche, educative, spirituali e, infine, giuridiche. Dall’insieme di queste analisi ne nasce un percorso che inizia con l’illegalità e termina con la svolta, cioè il passaggio alla legalità. In che misura ognuna di queste componenti influisce su percorsi di vita e scelte? Affermerebbe, inoltre, che tra questi elementi vi è un filo rosso?
Ognuno di noi ha una storia. Ognuno è una storia. Fatta di tante modulazioni. Tutte necessarie e tutte componenti la vita umana pur nella sua diversità. Le storie non si differenziano tra esse per quelle migliori o quelle peggiori. Ognuno ha il suo percorso. Quando si incontra una persona si incontra una biblioteca. Si incontra un mondo fatto di sentimenti, relazioni, provenienze, convincimenti, spiritualità eccetera. Non ci è dato di scegliere. Una persona è un “unicum”. Prendere o lasciare. Una cosa è certa ogni persona è un mondo una storia da accogliere, custodire, rispettare e includere. Così è stato per l’incontro avuto con Luigi Bonaventura per l’intervista a lui fatta e da cui è scaturito il libro “Passiamo all’altra riva”. Tutto concorre al cambiamento, al progresso, alla crescita di una persona. Ad un certo punto c’è qualcosa nella vita di ognuno che ci porta a virare. A cambiare. Un alcolista che aveva posto tutta la sua fiducia nel bere si accorge che così non è stato. Chi si è tuffato nei piaceri della vita constata che è stato tradito da essi. Chi credeva di fidarsi della violenza si accorge che è rimasto indietro rispetto ad altri. All’improvviso nasce qualcosa nel cuore che ci porta a cambiare, a metterci in discussione, a ripensarci. Inizia il cammino verso un’altra riva. In tutto e sempre c’è un filo rosso, l’importante è decidere da che parte si vuole stare.
Le mafie proliferano dove la fragilità è forte. Fragilità di un sistema economico, politico e culturale, detti elementi, come un circolo vizioso, conducono al degrado sociale. In realtà, le nostre azioni, individuali hanno la forza di rafforzare o bloccare questo meccanismo. Focalizziamoci, dunque, sul nostro agire.
Credo che nessuno deliberatamente scelga di essere mafioso a meno che non ne faccia, deliberatamente, il suo credo. Ma anche in questo caso diventa una scelta opportunistica, una scorciatoia. Sono convinto che come esiste un DNA biologico esista pure quello sociologico. Se nasco in un contesto familiare mafioso è facile che mi aggrego. Non conosco altri modelli che quello. Mi adeguo. Mi sembra normale. Anzi, gli altri mi appaiono particolari. Nessun uomo nasce delinquente. È sempre l’esempio ricevuto che determina la propria collocazione sociale, le proprie scelte professionali ecc. Certamente il degrado, la povertà, la fragilità di ogni tipo sono un humus particolarmente vocato a fare proseliti per aggregazioni malavitose e mafiose. La famiglia, la società, la scuola hanno perso il loro indispensabile compito educativo. La disgregazione delle famiglie, la frantumazione dei valori hanno permesso la frana della delinquenza, delle delegittimizzazioni, dello scoraggiamento, della deriva, del naufragio. Certo che tutto inizia da ogni persona ma ogni persona deve incontrare modelli positivi e propositivi. Urge recuperare terreno. Cultura, socializzazione, aggregazione sana e benefica.

Due fattori nella lotta alle mafie assumono rilievo: cultura ed educazione. Non è solo un problema di tribunali, magistrati o forza dell’ordine. Entriamo nel merito di questo discorso.
Certo, l’ho appena detto. Nessuno deve abdicare al suo primario, necessario, doveroso impegno di educare. La delega in campo educativo è perniciosa. Occorre stare al proprio ruolo, in primis la famiglia. Educare è un compito impegnativo e assai difficile. Diceva un grande santo che ha educato i giovani difficili della Torino del 700-800: san Giovanni Bosco: “L’educazione è questione di cuore”. Educare significa accompagnare, estrarre dal cuore di ogni persona tutto il bello e il buono che c’è. Anche un orologio rotto due volte al giorno segna l’orario esatto. Dalla vita di ogni persona c’è qualcosa di buono. Occorre individuarla e implementarla. L’educatore è una sorta di “talent scout”. Educare è un’arte, ma si educa proponendo e pretendendo il rispetto delle regole. La vera educazione è data dall’esempio. È la forma più eloquente, diretta e redditizia di educare. Ma purtroppo oggi in famiglia c’è la “baby sitter” domestica che è la tv o i cellulari. Non sono più le ginocchia dei genitori o dei nonni le prime cattedre, ma ben altro. Allora c’è la dissipazione, la maleducazione. Della cultura si potrebbe dire la stessa cosa. È necessaria, indispensabile. Uno Stato che non educa e non istruisce i suoi cittadini li tradisce e li abbandona. Questi sono delitti sociali. Questi sono i veri problemi e mio modesto avviso.

Nel suo libro emerge forte la conflittualità, il dualismo umano, riassunti nella figura di Luigi Bonaventura, il quale varca questo stato. Amore, fede e volontà di riscatto sono stati per quest’ultimo fondamentali.
Quando Luigi ha incontrato e conosciuto il vero amore, quello di sua moglie Paola e la conseguente nascita dei figli, allora si è accesa in lui la scintilla del cambiamento, della volontà di cambiare vita, di costituirsi. È l’amore la vera leva del mondo. Archimede disse: “Datemi una leva e vi solleverò il mondo”. Io direi mettiamo l’amore dove non c’è e tutto cambierà. La vera fame e sete del mondo di oggi è la fame e la sete di amore. La svolta nella vita di ogni uomo si ha quando incontra l’amore. Fortunato chi lo percepisce già in grembo materno. O lo conosce sin da piccolo. Lui, nato da mamma ‘Ndrangheta, bambino soldato, imbevuto di quella cultura che fu di suo nonno prima, di suo padre dopo, è stato “costretto” a ripercorrere la stessa strada che però non era della madre che, purtroppo, era succube di suo marito. Il calore dell’amore, conosciuto nell’incontro con sua moglie, ha ingenerato in lui la svolta. Ha conosciuto un altro mondo diverso da quello abitato fino ad allora. Per uno che mangia sempre lo stesso cibo, mangiarne uno diverso gli fa anche senso. L’importante, però, è che ne assaggi. Una volta assaggiato ne vorrà dell’altro.
Il discorso della fede in questo caso specifico ha ricevuto e sta ricevendo una maturazione più lenta e progressiva ma anch’essa ha la sua benefica influenza.
Cosa significa per un collaboratore di giustizia raggiungere la consapevolezza?
Nella vita di ognuno arriva un punto di non ritorno, un momento nel quale ti poni le domande oltre alle domande economiche: “hai un lavoro, sei ricco?”, quelle psicologiche, esistenziali: “Come stai? Come vivi? Per chi vivi?”. Solo allora scatta una sorta di coscientizzazione e realizzi che forse la vita materiale non è la sola, l’unica da vivere. Forse non solo il benessere economico è sufficiente a nutrire il cuore e la fame di altro che ognuno di noi porta in sé stesso. Quando questo accade, oltre ad altre modulazioni sentimentali e comportamentali, allora nasce il desiderio di altro. La famiglia, i figli, la fede, l’avvenire, il termine della vita fanno porre seri interrogativi e sono un forte impulso a cambiare vita, comportamento, scelte. Da qui nasce il desiderio di “passare all’altra riva”.
Nella prefazione Papa Francesco parla di “Correzione fraterna”, in tal modo abbatte ogni forma discriminatoria, veicola all’umiltà, ma soprattutto parla d’amore. Qual è la sua interpretazione di quest’espressione?
Questa espressione è desunta dal vangelo di Matteo (18,15-20) allorquando viene raccomandato di aiutare coloro che sbagliano. Gesù con arte pedagogica dice di chiamare in segreto colui che ha sbagliato e farglielo notare. Se non ascolta lo si richiama davanti la testimonianza di qualcuno. Se continua ad errare lo si porti innanzi l’assemblea. C’è da precisare che questo accompagnarlo alla comunità non deve avere il sapore della denuncia ma della consegna. La comunità deve riabilitarlo, riammetterlo alla relazione correggendolo. Correggere dal latino significa “reggere con”. Quando incontriamo qualcuno che ha sbagliato, correggerlo, allora, ci impegna ad essergli di aiuto a comprendere l’errore e rimetterlo sulla retta via, aiutandolo a portare il peso dei suoi errori. Tutti sbagliamo ma questo non ci autorizza a demoralizzarci e tanto meno ad autocondannarci.
Nessuno deve puntare il dito contro qualcuno. Tutti abbiamo bisogno di misericordia, di comprensione, di aiuto, di incoraggiamento. L’errore è e rimane un episodio di una vita e non è tutta la vita. Occorre correggersi per correggere. Usare misericordia per essere direbbe il papa “misericordiati”.
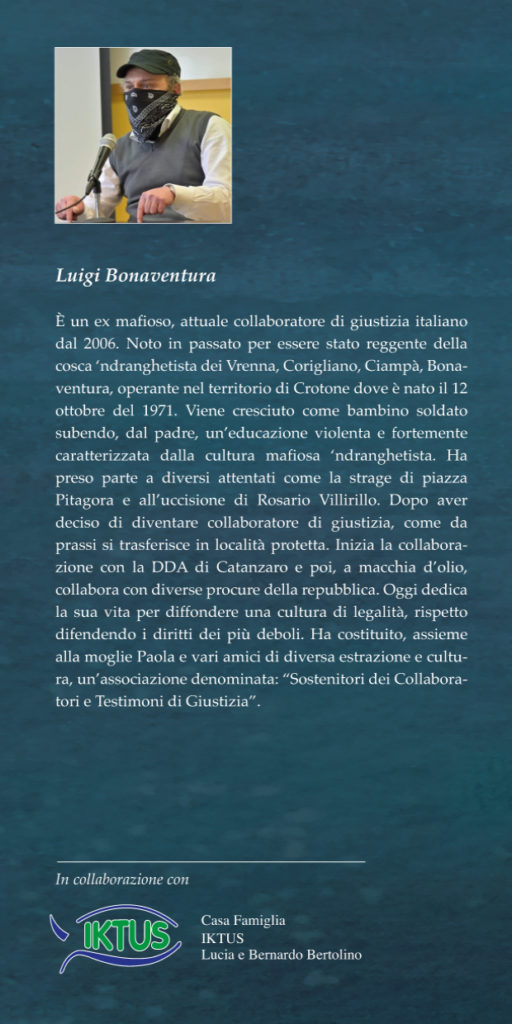
“Saper perdonare” e “sapersi perdonare” sono parti integranti di “Passiamo all’altra riva”, sono processi analitici e profondi che richiedono un lungo processo di crescita interiore.
Come si può, a suo avviso, raggiungere questa forma di equilibrio?
Arte difficile quella del perdono. Innanzitutto lo dice la parola stessa per-dono. Gratuitamente. Senza pretese. Senza tornaconti. Imparare a perdonare significa essere capaci di comprendere. La base di ogni perdono è l’amore. Se a sbagliare è qualcuno che mi interessa: un figlio, un coniuge, un genitore, una persona cara il bene che nutro per loro mi spinge a comprendere e perdonare. Il perdono è questione di amore vero verso se stessi e gli altri. Dobbiamo essere capaci di migrare sempre verso l’altra riva. Una riva che migliora il mio stato, la mia condizione, la mia vita. Un modo per essere capaci di perdonare ce lo indica sempre papa Francesco e lo ha scritto anche nella sua prefazione al libro stesso. “Nessuno ha il diritto di guardare gli altri dall’alto in basso, se non quando deve chinarsi per aiutarlo a risollevarsi”. Tutto è possibile se ci educhiamo alla logica del perdono. La condanna e l’esclusione sono modi dispotici e sbrigativi per relazionarci con gli altri. Occorre pazienza, attesa, misericordia, comprensione. Il vocabolario del mondo ha bisogno di purificazione di integrazioni, di rinnovamento. Solo così possono esserci margini di convivialità libera e serena altrimenti ogni uomo resterà condannato ad essere lupo per l’altro uomo. E sarà la fine. Ci sbraneremo tutti.
Infine, le chiedo: cosa si potrebbe fare per migliorare i programmi di protezione, a quanto pare, poco funzionali?
L’Italia ha una serie di leggi che regolano i rapporti con i collaboranti. Sono, a mio avviso, delle buone leggi, ma ormai obsolete. Occorre fermamente andare verso il cambio di generalità, si risolverebbero tanti condizionamenti. Si ridarebbe dignità alle persone, si rispetterebbero i loro diritti, avrebbero una vita meno tormentata. Ecco: immediato cambio di identità per tutti i collaboranti.
Mara Cozzoli





