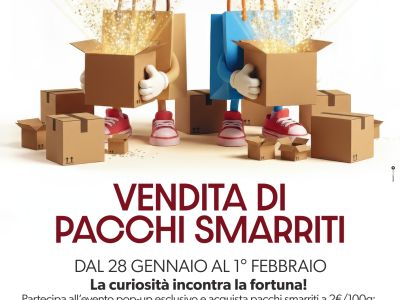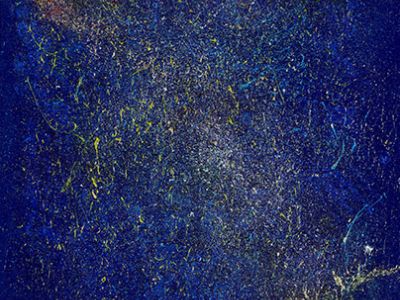Istituti penali e salute mentale: quando le carceri diventano l’ultima casa dei più fragili
“Pensava di essere diventato di ferro, tanto il suo corpo cigolava come il letto”. All’istituto penale di Milano Opera, nella sala Pannella, risuonano le parole del libro di Mariateresa DiLascia, ‘Passaggio in ombra’, Premio Strega, durante il workshop “Res vs Spem” organizzato dall’associazione Nessuno Tocchi Caino, che riunisce attivisti, studenti e detenuti.
Descrivere a più voci, per riconoscere e condividere la realtà di una situazione che fuori dalle mura viene definita di emergenza, ma che qui è la difficile quotidianità di non essere visti e ascoltati. Una realtà che tocca i più fragili, di cui si sente parlare di rado.
“Mariateresa Di Lascia racconta l’esperienza del carcere, come la cella e la branda sia diventato il suo rifugio, non distigue il giorno dalla notte, e passa le giornate che come un sudario ha lasciato le tracce dei corpi che c’avevano dormito prima di lui” spiega Sergio D’Elia, presidente di Nessuno Tocchi Caino.

“Il carcere è diventato un luogo dove si concentrano non solo problemi sociali, ma anche quelli di tipo psichiatrico. Finiscono in carcere gli emarginati sociali, le persone che hanno fatto abuso di sostanze e persone con dipendenze che hanno disagio psichico”. E continua: “Nelle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza, ci sono persone che sono certificate come semi inferme e totalmente inferme di mente. In molti casi chi ha un disturbo non viene accolto nelle REMS” e spiega: “questi istituti hanno solo 700 posti circa, le persone con patologie psichiatriche sono molte, molte di più. Tante persone dovrebbero stare in Centri per la Salute Mentale, in comunità di accoglienza per chi ha problemi di tipo psichiatrico” e conclude: “A volte ci sono decisioni a monte che vengono compiute tenendo presente solo i possibili costi, decisioni che vengono prese senza tenere conto che la migliore terapia è la relazione di qualità”.
Alcuni casi eclatanti che arrivano ai telegiornali sono storie come quella di Emanuele De Maria che si è gettato dal Duomo di Milano a maggio o la storia di Said, il ragazzo di 22 anni che si è tolto la vita al Milano San Vittore a fine giugno dopo essere arrivato dal Marocco.
In Lombardia, dove sono ospitate 8100 persone circa per una capienza di circa 6300 persone in 18 istituti e un istituto penale minorile – sono stati contati nel 2024 dodici casi di suicidio. La regione ha la maglia nera insieme a Campania, con undici casi, e Lazio con nove casi.
Un altro record negativo per la Lombardia è il sovraffollamento. La media del 147 per cento arriva a punte estreme come per il carcere di Milano San Vittore che ha tasso del 220 per cento, in confronto ad una media nazionale del 122 per cento.
La parola “sovraffollamento”, già nel 2013, era l’argomento per cui l’Italia veniva condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con l’accusa di aver infranto l’articolo 3 della Convenzione dei Diritti Umani che indica il “Divieto di tortura, trattamenti inumani e degradanti”. La più rilevante di una serie di sentenze della CEDU che fanno emergere gli inciampi del nostro Paese sul tema della tutela dei diritti dei detenuti.
Il risultato è che negli istituti penali – secondo il monitoraggio di Antigone, organizzazione impegnata su questo fronte – nell’80 per cento dei casi i tre metri di cella calpestabile per persona non sono garantiti. E insieme allo spazio mancano i servizi essenziali a tutela dei diritti.
Secondo l’ultimo report di Antigone, manca il personale impiegato in tanti ambiti, e questo porta a una pesante ricaduta sulle attività interne. In regione ci sono carenze sia sul fronte della polizia penitenziaria e si calcola una carenza di 487 unità, sia per quel che riguarda il personale contabile con 151 unità.
Valeria Verdolini, presidente di Antigone Lombardia, commenta: “All’aumentare delle persone detenute, negli istituti penali non aumenta il personale in servizio – penale o sanitario che sia – e i numeri attuali rendono difficile qualsiasi gestione che sia in grado di una presa in carico piena, o di un percorso trattamentale efficace in caso di patologie e problemi di salute”.
E mentre si continuano a ipotizzare soluzioni all’emergenza carceraria, la ricerca scientifica ha individuato qualche anno fa i fattori di stress che impattano sul benessere psicologico di chi vive dietro le sbarre. Una ricerca pubblicata nel 2021 su The Lancet, basata sull’analisi di oltre 35mila casi di suicidio in ambito carcerario e sull’aggregazione dei dati di 77 studi condotti in 27 paesi, ha portato alla luce due elementi ricorrenti: la presenza di disturbi psichiatrici diagnosticati e l’assenza di visite sociali. Quest’ultimo aspetto riguarda in particolare quei detenuti privi di una rete familiare o amicale, con cui poter intrattenere un contatto, anche minimo, capace di offrire sostegno emotivo.
Verdolini continua: “Abbiamo più del cinquanta per cento delle persone con background migratorio, un crescente fenomeno dei giovani adulti della fascia 18-24, a volte ex minori non accompagnati che spesso non hanno nessuno da sentire, chiamare o incontrare durante il periodo della detenzione” e spiega: “Diventa difficile per quelle persone che hanno poca rete amicale e pochi strumenti. Finisce che a farne le spese sono coloro che hanno meno possibilità” e conclude: “I numeri sono tali per cui i mediatori culturali oggi non sono sufficienti”.
Negli istituti penali lombardi oggi si contano circa 4mila persone con un background migratorio. Si tratta di un numero che si avvicina alla metà del totale, mentre complessivamente l’Italia ha un terzo di persone arrivate in carcere dopo una migrazione.
Ma c’è di più. Queste persone rappresentano il 44 per cento di tutti coloro che hanno compiuto crimini minori, coloro che sono detenute per scontare pene minime, che potrebbero avvalersi di misure alternative, ma che per assenza di un luogo sicuro, una casa con residenza dove trascorrere la pena, vengono detenute in carcere.
Ileana Montagnini, responsabile dell’Area carcere e giustizia di Caritas Ambrosiana, spiega: “Venti anni fa noi già vedevamo gli albori di un fenomeno che con il testo unico sull’immigrazione e con i successivi decreti sicurezza è andato intensificandosi”.
E continua: “Chi arriva sprovvisto di titolo di soggiorno o per qualche motivo lo perde, i cosiddetti irregolari di ritorno, si trova in una condizione giuridica doppiamente rischiosa: si tratta di persone che non hanno la possibilità di lavorare o risiedere regolarmente sul territorio, il che le espone a situazioni di forte fragilità e vulnerabilità”. E continua: “In queste condizioni, è più facile che vengano coinvolte in procedimenti giudiziari e, successivamente, nell’esecuzione penale. Tuttavia, in mancanza di un’abitazione oppure in presenza di un alloggio considerato non idoneo, l’esecuzione della pena può avvenire esclusivamente all’interno di una struttura carceraria. Non esiste, quindi, per loro un percorso di regolarizzazione: restano escluse dall’accesso a misure alternative alla detenzione e finiscono con lo scontare in carcere pene spesso più brevi rispetto a quelle previste per i cittadini italiani”. Barriere dento le barriere.
Ornella Favero di Ristretti Orizzonti, organizzazione e rivista che monitora e racconta la situazione delle carceri italiane, commenta: “Per le persone migranti il nodo è sentirsi abbandonati. L’unico strumento che funziona è lo sportello dedicato, che aiuti concretamente nella gestione delle pratiche burocratiche e consenta a ciascuno di orientarsi in un sistema complicato”. Favero considera: “Oggi servono vicinanza, ascolto, e strumenti reali. Se manca anche solo la possibilità di fare una telefonata, ogni percorso di dignità si interrompe”.
Articolo a cura di Laura Ghiandoni.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto di Journalismfund Europe
Ganzetti Raffaella